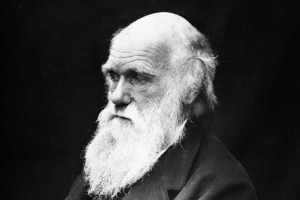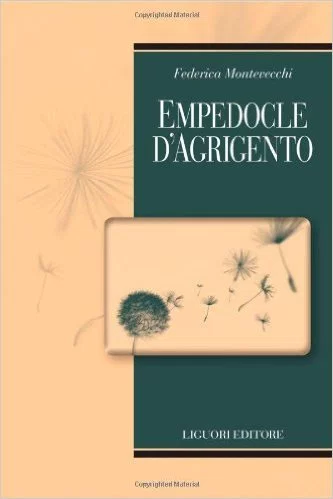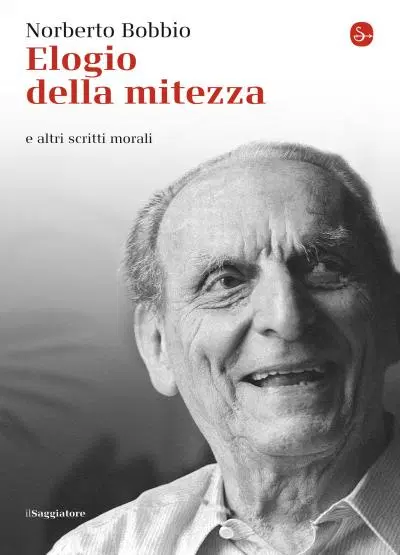> di Massimo Carloni*

Non mi aspetto più niente dalla vita
se non una sequenza di fogli di carta da scarabocchiare di nero.
Mi sembra di attraversare una solitudine senza fine,
per andare non so dove. E sono io che sono nello stesso tempo il deserto,
il viaggiatore, e il cammello!
FLAUBERT [1]
- Il gioco delle carte e l’isola di Robinson
L’opera cresce ai margini della vita, sulle sue rovine, nell’ «eterna tortura del morire»[2]. Essa emana dall’ombra, dal limbo di chi non è, né tanto meno aspira ad essere. La solitudine ne è la scaturigine. Il demone della scrittura sceglie il deserto, si nutre di negativo, d’assenza, di vuoto, per forgiare e distruggere il mondo nel fuoco della creazione, fino ad innalzarlo «nel puro, nel vero, nell’immutabile».[3]
Nel corso della sua vita Kafka ha percorso una terra di confine, fra «la solitudine e la società»[4]. Landa desolata, popolata di fantasmi, dove la tenebra sconfina nel giorno diventando luce, e la luce si fa tenebra; in cui la realtà stessa è continuamente minacciata, dilaniata dal sogno. In questa notte dell’anima si consuma per Kafka il dramma dell’esitazione, della lacerazione tra due imperativi categorici. Quello interiore della vocazione letteraria, lo isola proteggendolo dagli assalti terrificanti della vita; quello esteriore, rappresentato dall’implacabile universalità della Legge, lo spinge verso i doveri sociali di produrre e procreare, ossia: lavoro, matrimonio e, naturalmente, discendenza. Quando raramente varcherà quella frontiera, tentando di metter radici nello spazio della vita comune, se ne ritrarrà disgustato, annoiato, col rimpianto del tempo sottratto all’unico universo che conta: quello della scrittura[5]. Continua a leggere